Mentre Trump continua la costruzione del muro per fermare uomini, donne e bambini in fuga dal Centro e Sud America, il commercio di sostanze stupefacenti e armi con gli Stati Uniti prospera e punta all’Europa

di Fausta Speranza
L’ultima vittima conosciuta è una cronista di razza, Norma Sarabia, 46 anni, uccisa davanti a casa nella serata di martedì 11 giugno da due uomini in moto. «Indagava su episodi di malcostume nella polizia e aveva ricevuto minacce anonime», ha fatto sapere il giornale per cui lavorava, Tabasco hoy. In Messico non esiste solo il muro contro i migranti pianificato da Donald Trump, c’è anche la toccante esperienza di chi “fa muro” contro il narcotraffico, la corruzione, l’omertà, la non considerazione del valore della vita umana. Chi ne è protagonista rischia di persona, ma sono in tanti a non arrendersi.

È la storia coraggiosissima di una parrocchia di Acapulco e di un murale. Nessuna analogia con l’atmosfera da bella vita e jet set internazionale degli anni Sessanta. Oggi è un epicentro delle violenze collegate al traffico di droga e di armi che determinano nel Paese il record di 80 omicidi e sei persone scomparse al giorno. La chiesa della Sacra Famiglia ha risposto con un grande, coloratissimo murale, che alterna immagini e nomi delle vittime della criminalità nella zona, grazie ai fondi della Onlus italiana “Amici di Santina Zucchinelli” di don Luigi Ginami, che ha assicurato a padre Octavio Gutiérrez Pantoja, direttore della pastorale ad Acapulco, 22 mila euro.
Il filo spezzato di tante vite resta intrecciato nella memoria collettiva e disegnato su questo muro che rappresenta una sfida al grigiore e all’oscurità delle logiche di morte dei narcos. Una donna ci ha detto: «Abbiamo cadaveri fatti a pezzi per le strade e c’è la consapevolezza che tanti militari sono corrotti. Questo murale ha ridato colore alla nostra speranza».
I dati sono agghiaccianti: dal 2006, anno di inizio della presidenza di Felipe Calderon che dichiarò “guerra al narcotraffico”, 200 mila vittime, tra cui 50 sacerdoti (di cui 7 assassinati l’anno scorso, stando ai dati del Centro Católico Multimedial), e 35 mila desaparecidos, tra cui i 43 studenti sequestrati ad Ayotzinapa il 26 settembre 2014 da uomini in divisa e finiti nel nulla. Dal 2017, l’escalation si è impennata. Nel 2019, con l’assassinio di Norma Sarabia sono dieci i giornalisti uccisi, undici se si conta dal 1° dicembre 2018, giorno dell’insediamento del presidente Andrés Manuel López Obrador, detto Amlo.
Nel più meridionale Paese dell’America del Nord, dove scioccanti record di violenza convivono con l’irresistibile mix di natura, storia, cultura, arte, spiritualità, possedere un’arma è un diritto costituzionale, ma è diventato diritto di uccidere.
Dal Messico passano droga ed esseri umani in disperata fuga dal Centro America. E dagli Stati Uniti arrivano soldi e armi: per numerosi Stati non c’è un limite di transazioni. Quelle illegali in Messico vengono reperite con la formula dello straw purchase, l’acquisto di un bene o servizio per qualcuno e successivo trasferimento alla persona richiedente.
Da anni, la pressione dei migranti verso il Nord America comincia più a sud del Messico: da Guatemala, Honduras, San Salvador, che conoscono livelli di violenza ben peggiori ed estrema povertà. Circa 440 mila persone in media ogni anno. Ma di recente la novità è stata la mobilitazione di massa. Da ottobre ci sono state fino a ora sei grandi carovane di migranti: anche settemila persone, tra cui donne e bambini, in marcia tutte insieme, offrendo l’immagine di un “esodo biblico”. Una scelta dettata innanzitutto dal tentativo disperato di non cadere vittime dei trafficanti di esseri umani, di abusi, ruberie, e poi di richiamare l’attenzione del mondo.
Il presidente Trump ha risposto con un notevole dispiego di forze militari – 11 mila soldati – lungo il confine. Obrador sta cercando politiche di mediazione. Ha lanciato il piano Quédate en Mexico, rimanete in Messico, che prevede che tutti i richiedenti asilo agli Stati Uniti attendano la decisione in merito al loro caso in territorio messicano, secondo una sorta di esternalizzazione di servizi. E ha chiesto soldi a Trump per un piano di sviluppo da 20 miliardi di dollari per l’America Centrale. Tre quarti dei fondi dovrebbero servire alla creazione di posti di lavoro e alla lotta alla povertà, il resto al controllo delle frontiere.
Trump continua a parlare di muro, vecchia promessa della campagna elettorale. Ha cercato di imporre lo stanziamento di 18 miliardi di fondi al Congresso, arrivando al record di settimane di shutdown, cioè di bilancio federale bloccato dal braccio di ferro. Non l’ha spuntata e al momento ha ottenuto “solo” un miliardo dai fondi del Pentagono.
Dal 1994 Washington, sotto diverse amministrazioni, ha avviato e proseguito i lavori per una barriera e ha organizzato maggiori controlli, ma il muro pensato da Donald Trump è di cemento armato e non è solo fisico: i provvedimenti presi nell’autunno scorso hanno portato a separare bambini e genitori migranti, un “confine” che mai dovrebbe essere ammesso. Per fortuna la risposta della magistratura statunitense c’è stata, oltre all’indignazione mondiale, e almeno questo “muro” sembra sgretolato. Ma la particolarità di Trump sta anche nelle paventate politiche interne in tema di migranti, che fanno tremare i tanti messicani che si trovano già sul territorio: migliaia, per esempio, impegnati a lavorare nei campi in California temono l’espulsione. La frontiera ovviamente ha una storia. Dopo la fine della guerra tra Stati Uniti e Messico nel 1848, diventa una zona grigia del contrabbando, mai davvero combattuto. Poi sono arrivati i traffici di armi e di cocaina. Le sostanze stupefacenti rimbalzano dall’America Centrale in America del Nord, in Africa, in Europa e ormai anche in Cina, dove si “arricchiscono” di materie chimiche che a buon mercato aiutano a seminare morte.
Un esempio dei tentacoli che arrivano in Europa ci porta in Italia: rapporti Onu e procuratori locali attestano che nell’ultimo anno in Calabria i narcos messicani hanno sorpassato i colombiani per quantità di cocaina venduta, con una caratteristica: non si accontentano di esportare, ma contendono alla ’ndrangheta la gestione del territorio. È contro tutti questi traffici che andrebbero eretti muri, solidi, che invece non si vedono.
da Famiglia Cristiana del 1 luglio 2019

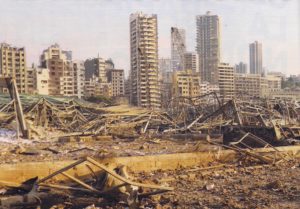












 Zheng Xiao Yun
Zheng Xiao Yun