Il 28 settembre 2023
su gentile invito dell’Associazione Omnibus Omnes OdV



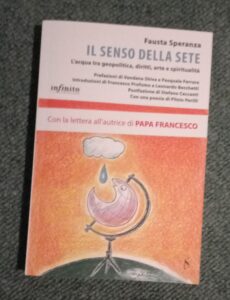


foto e video
by Cinzia Cagliesi e Gemma Codella, meravigliose amiche di una vita
Il 28 settembre 2023
su gentile invito dell’Associazione Omnibus Omnes OdV



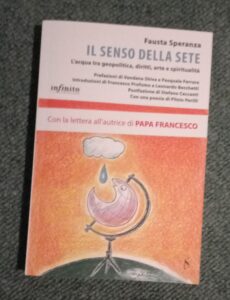


foto e video
by Cinzia Cagliesi e Gemma Codella, meravigliose amiche di una vita
15 Settembre 2023
su Radio Marconi https://www.radiomarconi.info/palinsesto-2
rubrica Radio Aperta, Approfondimenti sulle notizie del giorno (10.30-12:00)
si parla del “Tempo del creato” e della questione acqua
il collega Bruno Cadelli intervista Fausta Speranza
autrice del volume Il senso della sete (Infinito Edizioni, ristampa aggiornata luglio 2023)
Si parla delle più recenti questioni legate alle risorse idriche:

«Senza nessuna commissione ecclesiale»: è quanto sottolinea suor Linda Pocher parlando di come sono nate le tre diverse iniziative cinematografiche dedicate a Maria che l’hanno colpita e stimolata a tal punto da scrivere Immagini di Maria. Immagini della donna dedicato, come recita il sottotitolo, a Cinema e mariologia in dialogo (Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 2023, pagine 176, euro 14). Tre film che nella penna dell’autrice, docente all’Auxilium e membro del Consiglio della Pontificia Academia Mariana Internationalis, diventano uno strumento della sua appassionante ricerca sulla mariologia contemporanea.
Se non si possono individuare committenze precise per i film o per il volume, ci sono invece almeno tre punti fermi che risuonano come ideali ciak di incoraggiamento: la costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio vaticano II che, come sottolinea l’autrice, «incoraggia a fare alleanza con la “settima arte” e la sua potenza comunicativa»; l’esortazione apostolica di Paolo VI Marialis cultus che «invita a rinnovare l’immagine di Maria incrociando la Scrittura, le scienze umane e le esigenze degli uomini e delle donne di oggi»; e il libro di Papa Francesco Ave Maria (Rizzoli-Lev 2019) in cui si racconta Maria come «una ragazza normale» incoraggiando a non rimanere ingabbiati nell’immaginario miracoloso del dogma.
«Quando Maria viene rappresentata come troppo diversa, separata e distante dall’esperienza umana — spiega Pocher —, si rischia di favorire processi di idealizzazione religiosa che allontanano dalla realtà quotidiana». Non si tratta di sminuire il linguaggio che opportunamente esprime i fondamentali aspetti della potenza divina, della liberazione dal male, della felicità promessa, ma di illuminare maggiormente le esperienze di Maria che meglio aiutano a comprendere le umane difficoltà, come i momenti di ansietà, di sofferenza, di oscurità, di impotenza, «di contrasto», afferma l’autrice. Il punto essenziale è non perdere il contatto con la situazione personale in cui di fatto ognuno attua il proprio percorso di vita e il proprio cammino di fede.
Il libro illustra i frutti di un approccio interdisciplinare: tutto è partito infatti dal seminario organizzato dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma in cui tre film italiani che hanno come protagonista la Madre di Dio sono stati messi a confronto, in un vivace dibattito, con gli studi più recenti su Maria. Si tratta di Io sono con te (2010), del regista Guido Chiesa che si è valso della sceneggiatura di Nicoletta Micheli; Troppa grazia (2018) diretto da Gianni Zanasi e sceneggiato da Michele Pellegrini; Bar Giuseppe (2019) di Giulio Base. Ne è emersa una riflessione attualissima, anche perché i film sono recenti. Ed è stata “aggiornata” anche la lente di lettura del gesuita Nicolas Steeves, studioso di teologia; dell’esperta di scienze psicologiche suor Milena Stevani; di don Renato Butera, docente di Comunicazione sociale; di Katia Malatesta, relatrice e giurata a vari festival internazionali di cinema. Peraltro il passaggio dalla modalità cinematografica a quella di videoconferenza e poi alla scrittura aggiunge alla caratteristica dell’interdisciplinarietà quella della multimedialità. E il rimbalzo in realtà non finisce qui perché Pocher riferisce qualcosa nel libro anche dell’eco che queste tematiche hanno suscitato nei suoi studenti.
Tra i diversi punti di vista, una lettura in chiave psicologica si sofferma sulla peculiarità del rapporto di ognuno con i genitori e ancor più con la madre. Un rapporto con cui si deve fare i conti, nell’equilibrio tra lati positivi e lati negativi, se si vuole approcciare davvero la maturità. Si parte dalla consapevolezza dell’importanza dei processi di memoria e delle informazioni sensoriali e psicologiche ricevute nell’ambito delle relazioni familiari per poi indagare il ruolo dell’immaginazione e di quella che viene definita la «mappa interiore», la rete di rappresentazioni che sono alla base del senso di sé e dell’altro. Il punto è che è importante un’equilibrata elaborazione personale che porti a una percezione realistica in grado di accogliere la complessità delle relazioni, lasciando cadere aspettative illusorie di rapporti gratificanti e senza ombra di conflitto o resistendo a forme di rifiuto di limiti non accettati. Tutto ciò aiuta a comprendere proprio quell’adesione al percorso di vita e di fede di cui si parlava.
Nella scrittura intensa ma agile del libro emerge chiaramente il rischio di una idealizzazione della figura di Maria che non tenga conto degli aspetti di limite, del momento della frustrazione, dell’incontro con ostacoli e difficoltà. «Quando le dinamiche idealizzanti sono troppo accentuate — afferma Pocher — i modelli si ammirano e si esaltano, e si amplificano così i vissuti affettivi di entusiasmo, ma non avviene poi un passaggio ulteriore alla propria vita concreta».
In definitiva, la sintesi e la rielaborazione di Pocher offrono un contributo al rinnovamento contemporaneo della mariologia che è in atto.
Tutto concorre a rilanciare oggi quegli inviti del Concilio e di Paolo VI che secondo Pocher chiamano all’appello insegnanti e operatori pastorali perché «sfruttino maggiormente il cinema quale strumento per la formazione e l’evangelizzazione».
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-08/quo-186/nella-mappa-interiore.html
Al di là del cerchio di fuoco. È tornata a essere luogo di accoglienza e di preghiera la cappella di Saint-Michel de Brasparts nella suggestiva Bretagna. Siamo all’estremo nord-ovest della Francia, sulla sommità del colle omonimo, il più alto dei Monts d’Arrée, dove alla fine del XVII secolo la devozione locale diede vita alla piccola chiesa. Si può immaginare l’apprensione quando nell’estate 2022 i poderosi incendi che hanno colpito la costa occidentale della Francia sono arrivati a danneggiarla, dopo aver distrutto 2.200 ettari del bosco circostante. Nei giorni scorsi è stata riaperta al culto grazie al prezioso restauro effettuato in tempi di record e con una committenza d’eccezione: per il nuovo arredo liturgico è stato chiamato il disegnatore Ronan Bouroullec, originario proprio della Bretagna.
L’edificio è modesto, a pianta rettangolare, con abside inclinata. Le pareti, spesse più di un metro, sono il tratto fisico della profondità che si coglie. I muri in pietra intonacati a calce e il pavimento in terra battuta, leggermente rialzato nella zona del coro, richiamano la semplicità. La sensazione di una continuità tra la Cappella di Saint-Michel e il suo sito — tra architettura e natura — è forte. C’è il tetto in ardesia delle colline di Arrée, che poggia su un telaio di quercia.
L’impegno di Ronan Bouroullec si avverte proprio in linea con questa continuità, che è anche continuità con la tradizione del luogo e con l’impiego di maestranze locali. Nei materiali ha lasciato la sua impronta particolare anche scegliendo alcuni elementi particolari, come i residui minerari dell’altare in granito o il vetro smaltato per il contro rosone, che ben si armonizzano con la luce naturale e con quella delle candele, ospitate in essenziali ma eleganti supporti in ferro battuto. Si tratta di due gruppi di candelieri, uno formato dai tre grandi candelieri incastonati nella base in granito accanto all’altare, l’altro da ben quattordici candelieri incastonati nella consolle in granito. Sulla cima di ognuno c’è una coppa, che accoglie candele diverse per forma e dimensioni: da un grande cero a un modesto lumino.
Della cappella ci parla Martin Bethenod, impegnato da anni nel campo della cultura e dell’arte contemporanea in Francia, attualmente presidente del Crédac-Centre d’art contemporain di Ivry e presidente degli Archives de la Critique d’Art. «Progettare un oggetto, uno spazio — spiega —, è un tentativo di produrre, sulla base di pochi elementi selezionati e interconnessi, un effetto che vada oltre i materiali, gli oggetti e il luogo stesso, per suscitare la sensazione che qualcosa stia accadendo e metta in moto cambiamenti». Il progetto di Ronan Bouroullec «si basa su un triplice approccio: trovare un vocabolario di materiali ridotto all’essenziale; trovare un equilibrio tra un senso di massa e di leggerezza; trovare la vibrazione nelle cose attraverso il trattamento delle superfici e della luce». C’è poi «l’aspetto fondamentale» dell’intuizione che — afferma sempre Bethenod — «non riguarda tanto il fornire una risposta specifica a una domanda diretta quanto dare vita a un’esperienza».
A proposito della cappella restaurata, Martin Bethenod sottolinea che «fornisce il contesto ideale per questo tipo di processo: provocando una temporanea sospensione del movimento e del suono del mondo circostante»: il suo essere luogo di culto e di riflessione genera «particolarissime sfumature di silenzio, di concentrazione, di contemplazione, di attenzione al mondo e a se stessi». E c’è da dire che i moti dell’animo si intensificano quando si arriva in un posto dopo un’arrampicata, con il paesaggio e il cielo negli occhi.
Nella mente di Bouroullec — racconta lo stesso artista — «il ricordo degli incendi che avevano colpito la regione già negli anni Settanta e l’immagine impressa nella memoria del paesaggio annerito su cui spiccava in contrasto la forma più pallida della cappella fanno parte dell’esperienza che è sempre radicata in un’impressione che è tattile, uditiva, olfattiva». In effetti l’aspetto della sensazione fisica — la penombra, l’umidità, la sensazione della pietra, il rapporto del proprio corpo con gli spazi — indubbiamente si ritrovano nel progetto per Saint-Michel de Brasparts.
Un’esperienza è immediata per tutti. Mentre la porta della facciata principale della cappella è usata solo raramente, la porta esposta a sud è senza chiave: sempre aperta. Una scelta precisa per un luogo voluto come rifugio dell’anima per escursionisti, pellegrini, passanti. E infatti con il suo garbo di essenzialità, l’interno della cappella accoglie chiunque cerchi raccoglimento.
La gioia di vederla restaurata e restituita al culto è anche la gioia di vedere valorizzati luoghi per la preghiera, per il silenzio e per l’ascolto che hanno il privilegio di essere in dialogo con la storia e con la natura.
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-07/quo-168/sulla-cima-del-silenzio.html
«Modelli concreti di fraternità»: così monsignor Angelo Vincenzo Zani, Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ha definito l’iniziativa — presentata nella mattina del 19 luglio presso la Biblioteca Apostolica Vaticana — di un corso di studio sui manoscritti ebraici custoditi dalla Biblioteca stessa, in collaborazione con il Seminario Rabbinico Latinoamericano Marshall T. Meyer. Il Rabbino Ariel Stofenmacher, rettore del Seminario, che ha sede a Buenos Aires, ha parlato di «un onore straordinario» e ha sottolineato che si tratta di «un corso storico». All’inaugurazione hanno partecipato autorità religiose e vaticane e autorità dei governi di Israele e Argentina.
Si tratta di un programma di formazione specialistica che prevede una settimana intensiva di lezioni (in presenza e a distanza) che saranno seguite da studenti di varie università del mondo e di diverse religioni. A tenere i corsi sono stati chiamati docenti di spicco, fra cui i rabbini Adolfo Roitman, David Golinkin e Ariel Stofenmacher; Judith Olszowy-Schlanger, Craig Morrison, Leonardo Pessoa, Sarit Shalev-Eyni, Marco Morselli, Stephen Metzger e Delio Vania Proverbio.
Si comprende l’entusiasmo di tutti per questo impegno di studio, considerando il patrimonio culturale e religioso in questione. Stiamo parlando, infatti, di una delle collezioni più importanti al mondo, soprattutto per l’originalità delle copie e delle versioni testuali che hanno fatto luce sulla ricerca di opere fondamentali dell’ebraismo. Si tratta di centinaia di manoscritti tra cui si distinguono rotoli di Torah, testi biblici e di esegesi, letteratura rabbinica, filosofia ebraica, libri liturgici, poesia, scienza e testi cabalistici.
L’emozione che si è avvertita nella Sala Barberini della Biblioteca Vaticana, dove si è svolta la presentazione, ben si accompagna alla consapevolezza del salto temporale: la maggior parte dei manoscritti risalgono al periodo compreso tra il XII e il XV secolo, altri affondano le loro radici tra il IX e l’ XI secolo. Il pensiero va a circostanze e fatti storici come le Crociate, l’Inquisizione, l’espulsione degli ebrei dalla Spagna.
L’antefatto che ha reso possibile questa coinvolgente esperienza di collaborazione culturale ci riporta al dicembre 2022: in occasione di una prima visita, le autorità del Seminario hanno potuto analizzare per la prima volta i manoscritti ebraici. Da lì è nata la proposta di un programma di studio che coinvolgesse studenti e specialisti di tutto il mondo. Ha preso, dunque, il via il processo di analisi e di confronto tra équipe professionali che ha elaborato il progetto per la realizzazione del corso. In particolare, alla presentazione è stato sottolineato il ruolo avuto per quanto riguarda la Biblioteca Apostolica da Claudia Montuschi, Scriptor Latinus e direttrice del Dipartimento dei Manoscritti, e da Delio Vania Proverbio, Scriptor Orientalis e curatore delle collezioni africane e del Vicino e Medio Oriente.
La dimensione internazionale degli studiosi coinvolti certamente non sorprende pensando alla vocazione universale della Chiesa e della Biblioteca Apostolica Vaticana e considerando il Seminario Rabbinico Latinoamericano Marshall T. Meyer, che è la principale istituzione accademica ed educativa ebraica in «Iberoamerica». Trae origine dalla fondazione a Berlino nel 1819 del gruppo Organizzazione per la cultura e la scienza ebraica, composto da sette intellettuali tra cui Eduard Gans, Heinrich Heine e Leopold Zunz. Ma è quando, tra le due guerre mondiali, diversi studiosi e rabbini di formazione europea hanno raggiunto l’America Latina che, insieme con il Seminario Teologico Ebraico di New York, è maturata l’idea del Seminario di Buenos Aires, fondato nel 1962 sotto la guida del rabbino Marshall T. Meyer. Da sempre la sua missione — ci hanno spiegato — è quella di «contribuire a trasformare il mondo attraverso l’istruzione, la formazione di studiosi, leader laici e religiosi, educatori e la promozione dei diritti umani e del dialogo interreligioso».
Nelle parole del rabbino Stofenmacher, che lo guida attualmente, la storia del seminario si arricchisce oggi di un capitolo preziosissimo: l’iniziativa con la Biblioteca Apostolica rappresenta «un’occasione per dialogare, condividere sapere e studi, impegnarsi ricordando al mondo la profonda responsabilità nei confronti delle eredità culturali». Di responsabilità ha parlato anche monsignor Zani auspicando che «la famiglia umana contrasti e superi una certa forma di sentire dilagante che vuole l’uomo contro l’altro uomo». Il riferimento esplicito è alla Fratelli tutti di Papa Francesco che ha denunciato «la mancanza di orizzonti in grado di farci convergere in unità» se si distrugge «lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana». È altrettanto chiaro il prezzo da pagare: «Il nostro mondo avanza in una dicotomia senza senso, con la pretesa di garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia». L’impegno deve essere da parte di tutti e a tanti livelli, anche ad esempio in quella che monsignor Zani ha definito «la diplomazia della cultura».
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-07/quo-165/modelli-di-fraternita.html
 INCONTRI LETTERARI
INCONTRI LETTERARI 23 luglio 2023
incontro con gli Autori vincitori della XIX edizione del Premio Letterario Nazionale “CITTA’ DI MESAGNE”
– Fausta SPERANZA 1° Premio Saggistica con “Fortezza Libano”


Fausta Speranza intervistata da Katiuscia DI ROCCO, direttrice Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” – Brindisi


– Gabriella CINTI 1° premio Poesia edita con “Prima”
– Marcello LOPRENCIPE 1° premio Narrativa con il romanzo “Olmo”
Conduzione: Flavio Dipietrangelo, Marina Poci, Pantaleo Ancora Assistenza: Soci e Collaboratori Volontari della Associazione.
https://quimesagne.it/incontri-letterari-2/
Accesso libero. In caso di avverse condizioni meteo, l’evento avrà luogo nell’Auditorium del castello
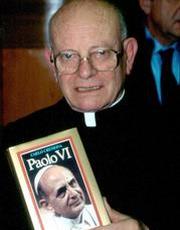
«Col tono giusto si può dire tutto, col tono sbagliato nulla: l’unica difficoltà consiste nel trovare il tono». Viene in mente questa celebre frase di George Bernard Shaw pensando a padre Carlo Cremona, sacerdote rigoroso, intellettuale mai elitario, giornalista appassionato e ironico, morto a 85 anni per un malore il 13 luglio 2003 proprio in uno studio televisivo. Vent’anni dopo, ricordiamo che è stato il primo comunicatore radio nel genere religioso — voce familiare per varie generazioni a Radio Vaticana e a RadioRai con il suo appuntamento Il santo del giorno — e che per primo ebbe l’idea di commentare in radio e in tv il sabato sera il testo del Vangelo della liturgia domenicale. Restano esemplari la capacità di parlare di tutto e la penna sagace contro falsi profeti e facili dottrine, ma anche la capacità di discernere quando tacere. Una penna che per anni ha assicurato al quotidiano «Avvenire» contributi brillanti, anche in difesa del «buon giornalismo cattolico» che — scriveva — «deve tornare alle notizie vere e all’informazione vera».
Torna alla mente il modo estremamente amabile con cui incarnava idealismo e umanità. Era stato agostiniano prima di essere diocesano e parroco a Roma della centralissima Santa Maria del Popolo, dove ha intessuto amicizie durature con personaggi del cinema come Marcello Mastroianni e Alberto Sordi. Sono sempre stati tanti, e di diverse discipline, gli artisti che ha frequentato, intessendo proprio per questo motivo un contatto diretto con monsignor Pasquale Macchi, segretario personale di Paolo VI, il Papa che ha costruito un dialogo importantissimo con artisti e intellettuali e che, presentando le conclusioni del Concilio vaticano II, ha chiarito come «la Chiesa è in profonda comunione con il mondo moderno, pronta ad accogliere le sue sfide e a offrire il rimedio ai suoi mali, la risposta ai suoi appelli». Alla morte di padre Cremona, monsignor Macchi ha sottolineato quanta stima avesse Papa Montini per «questo testimone coraggioso della verità e della libertà della fede cristiana, che ha coinvolto lettori e ascoltatori nella profondità delle riflessioni importanti seminando serenità e fiducia». Quanti hanno conosciuto padre Cremona immaginano l’umana gioia che avrebbe provato alla canonizzazione di Paolo VI, il 14 ottobre 2018.
I libri di padre Cremona hanno fatto letteralmente il giro del mondo: la biografia Agostino di Ippona (Rusconi, 1986) e il volume costruito a capitoli tematici Agostino d’Ippona. Pensieri (Rusconi, 1988) sono stati tradotti in pochi mesi in tante lingue, compreso il coreano di cui l’autore ci raccontò di essere particolarmente fiero. Agostino è uno di quei personaggi che corrono il rischio di essere considerati praticamente immobili nella loro immensa statura, mentre nella scrittura estremamente competente e allo stesso tempo accessibile di Cremona emerge l’uomo nel quotidiano, nella sua sofferta ricerca di verità e nell’abbraccio alla «Bellezza immortale». Sullo sfondo, è delineato il quadro storico e sociale, l’affacciarsi di popoli e forze a un tempo feconde e dirompenti, il sacco di Roma del 410 e l’inizio di una nuova era. Cremona non si limita a raccontare l’incontro tra mondo antico e pensiero cristiano, ma offre al lettore un ponte tra passato e futuro: nella sua rievocazione, Agostino cammina con l’uomo contemporaneo.
Altrettanto precisa e coinvolgente è la biografia — con un capitolo che parla del drammatico rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro — dedicata proprio a Paolo VI , che padre Cremona ha seguito in modo particolare. È stato Papa Montini a volerlo dal 1973 a Palazzo Migliori, costruzione settecentesca in largo degli Alicorni con vista sul colonnato di San Pietro. Palazzo Migliori oggi per volontà di Papa Francesco ospita persone senza fissa dimora in attesa che, superate le difficoltà, possano trovare un’abitazione. All’epoca di padre Cremona ospitava la casa per ragazze madri delle suore calasanziane Pio XI ed era una sorta di “ufficio stampa” delle tante iniziative che il sacerdote promuoveva — con uno slancio al quale era impossibile resistere — per sostenere attività caritatevoli delle religiose nel mondo, a partire dalla missione a Salvador de Bahia in Brasile.

Delle suore che si incontravano a Palazzo Migliori in quegli anni e’ ancora viva suor Emiliana che, a 98 anni compiuti a gennaio scorso, si trova nella residenza a via delle Calasanziane. Parla poco ma sorride molto e i suoi occhi si illuminano di serena ammirazione quando, andando a trovarla, le si parla di padre Carlo.
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-07/quo-157/rigorosa-liberta-di-scrittura.html








 “The sense of thirst”
“The sense of thirst”Ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Santa Sede
https://gazzettadiplomatica.it/lambasciatore-usa-donnelly-alla-presentazione-di-the-sense-of-thirst-di-fausta-speranza/
giovedì 6 luglio a Roma ore 16:00 a Palazzo Maffei Marescotti, a Roma
insieme con la proiezione del video Mis-En-Scene
https://www.meridianoitalia.tv/index.php/ambiente/570-se-l-acqua-e-sacra
di Paolo Minnielli 
(nella foto Paolo Minnielli con la concertista Antonella Tondi che lo ha accompagnato alla chitarra)
regista Stefano Gabriele
(con la partecipazione del Rabbino Ariel Di Porto; del Segretario Generale della Grande Moschea di Roma Abdullah Redouane; della teologa L. Pocher)



con il Maestro Lucio Trojano
autore del disegno della copertina 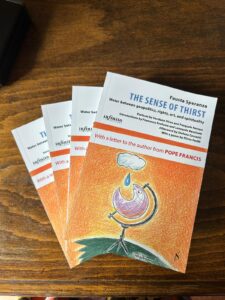

Mentre cerchiamo di capire cosa succederà al gigante russo e al popolo ucraino e mentre crescono le paure in Europa, dobbiamo ragionare seriamente su cosa sia una vera politica per la pace: non consiste solo nel mettere fine ai conflitti e nel contribuire a una stabilizzazione tra una guerra e un’altra, ma presuppone di guardare a tutte le politiche – socio-economiche e ambientali in primis – dalla prospettiva della pace, perché si possa evitare la nascita stessa di tensioni sociali e di nuovi conflitti. Significa occuparsi della annosa questione della produzione e della distribuzione delle risorse, a partire dalla più preziosa di tutte, l’acqua.
È quello che fa Il senso della sete, uscito a giugno 2023 in ristampa aggiornata in lingua italiana e in lingua inglese – in cartaceo e in ebook – con il titolo The sense of thirst. Water between geopolitcs, rights, art and spirituality, a conferma dell’interesse crescente per un testo che si occupa di questione ambientale con un approccio sinergico tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità.
Il libro:
The sense of thirst INFINITO EDIZIONI(€ 21,00 – pag. 256)
With a letter to the author of Pope Francis
Synopsis: the deep link between water and the right to health is one of the themes dealt with in denouncing the urgent social and geopolitical issues inherent in the most essential of human resources. In an era marked by the pandemic, by environmental disasters linked to climate change, by the phenomenon of Earth Overshoot Day, water is “analysed” as an emblem of the planet’s natural balance that human beings cannot destroy without annihilating themselves. The denunciation of issues that cannot be postponed, such as the ever less obvious right of access to drinking water, or drought, the cause of conflicts and migratory flows, is accompanied by an analysis of the spiritual, cultural and artistic dimension with which man has looked to the natural element, the source of life par excellence. The cry of the scientists, in fact, is waiting to be re-launched by a powerful leap of ethical awareness. Lest we forget that, as the philosopher-anthropologist Loren Eiseley said, “If there is any magic on this planet, it is contained in the water”.
L’Autrice
Fausta Speranza giornalista inviata. Al Radiogiornale internazionale di Radio Vaticana dal 1992; a L’Osservatore Romano dal 2016: prima donna a occuparsi di politica internazionale e poi nella redazione cultura. Ha lavorato con Sergio Zavoli (RaiTv Diario di un cronista e Viaggio nella scuola, 2000-2001). Ha firmato per Rai Storia nella rubrica Documentari d’autore il reportage dal Messico Tra record di violenza e di bellezza (8 Giugno 2019). Collabora o ha collaborato con Famiglia cristiana, Limes, RadioRai, il Corriere della Sera (intervista esclusiva alla super testimone del caso Spallone, aborti clandestini). Ha realizzato reportage anche da Europa, Canada, Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente, Africa. In Ghana ha documentato, entrando con la macchina da ripresa, il disastro di una delle più grandi discariche illegali di rifiuti elettronici al mondo. È autrice, per Infinito edizioni di Messico in bilico (2018), Fortezza Libano (2020) e Il senso della sete (2022; ristampa aggiornata a giugno 2023 in italiano, in inglese e in francese).
Ha vinto premi in sezioni Radio, Tv e Libri, tra gli altri: Premio Letterario Ambasciatori presso la S. Sede 2022; Premio Bizzarri al Giornalismo internazionale 2019; Premio Giustolisi al Giornalismo di Inchiesta 2018; Premio Giornalismo Europeo 2011.
Per informazioni:
Infinito edizioni: 059/573079 – 331/2182322
Lo sgretolamento dell’io identitario nella conflittuale dualità tra Bene e Male
Con le definizioni di sosia, gemello, ombra, immagine allo specchio, alter ego, il tema del doppio ha attraversato l’immaginario artistico letterario di tutti i tempi, interpellando la riflessione filosofica prima di incontrare le interpretazioni della psicanalisi. Tra mille suggestive o bizzarre variazioni di senso, un filo rosso non ha mai abbandonato l’idea di dualità o di alterità, anche quando ha cominciato a sgretolarsi la certezza dell’io identitario: il filo rosso è stata la consapevolezza di muoversi sempre e in ogni caso tra Bene e Male. Nell’era della cosiddetta intelligenza artificiale si parla di “gemello digitale”. Non è solo una possibile variante della creatività umana, ma è un nuovo scenario antropologico da considerare con grande attenzione. Per la prima volta quel filo rosso potrebbe essere spezzato dai processi di automazione.
Se nell’arte e nella letteratura il “doppio” — spesso citato con il termine tedesco Doppelgänger — è una metafora del lato oscuro dell’uomo, nel pensiero psicologico novecentesco il doppio rappresenta l’inconscio. Diventa funzionale alla spiegazione dei fenomeni di straniamento e dissonanza.
Il tema del “doppio” è stato studiato con particolare attenzione da Otto Rank, allievo di Sigmund Freud, nella sua opera Der Doppelgänger del 1914, in cui collega l’improvviso pararsi innanzi a noi di un sosia, un nostro “doppio”, all’emergere di paure rimosse. È un’invasione dell’inconscio nel campo del conscio, un ritorno del rimosso che diviene, secondo una definizione di Freud, «perturbante». Semplificando, per la psicanalisi il “doppio” è la parte “altra” di noi, ciò che siamo ma non conosciamo razionalmente. Si distrugge così l’archetipo umano prevalente ancora nell’immaginario post-illuminista e si apre la strada a un’umanità dall’identità indefinita, a un vero e proprio arcipelago dell’io in continua mutazione. Ma non è ancora persa l’idea di bene e male.
Nell’epoca di rivoluzione digitale che stiamo vivendo il Digital Twin, gemello digitale, è una delle figure nascenti della cosiddetta intelligenza artificiale. Un gemello digitale funziona replicando una risorsa fisica nell’ambiente virtuale, comprese le sue funzionalità, caratteristiche e comportamento. Si utilizzano sensori intelligenti che raccolgono dati dal prodotto. L’espressione «internet delle cose» si riferisce alla rete collettiva di dispositivi connessi che facilita la comunicazione tra dispositivi e sistemi cloud, nonché tra i dispositivi stessi. E i gemelli digitali si affidano ai dati dei sensori per trasmettere informazioni dall’oggetto del mondo reale all’oggetto del mondo digitale. Stiamo familiarizzando con termini come piattaforma software o dashboard dove in sostanza è possibile visualizzare l’aggiornamento dei dati in tempo reale. Fin qui si parla sostanzialmente di oggetti ma l’intelligenza artificiale ( IA ) è un campo delle scienze informatiche dedicato alla risoluzione di problemi cognitivi comunemente associati all’intelligenza umana, come l’apprendimento, la risoluzione di problemi e il riconoscimento di modelli. Dunque, per machine learning ( ML ) si intende la tecnica in grado di sviluppare algoritmi e modelli statistici utilizzati dai sistemi informatici per lo svolgimento di attività senza istruzioni esplicite e basandosi, invece, su modelli e inferenza. È la tecnica usata dai gemelli digitali e questo significa che il digital twin si sta affermando con forza nell’industria ma tende inesorabilmente a estendere il proprio dominio anche alla sfera privata degli utenti. Ed è qui che impallidisce la consapevolezza del bene e del male perché significa non solo orientare ma anticipare scelte e comportamenti. È evidente che si pongono questioni di etica in un mondo in cui soggettività e oggettività stanno perdendo di significato e le fake news dilagano. Non è detto infatti che i sistemi di intelligenza artificiale prevedano valutazioni etiche e nel caso le prevedano non sappiamo quali saranno i valori ispiratori.
In un’epoca di relativismo culturale e di derive autocratiche, non possono essere solo le multinazionali con le loro logiche di profitto a gestire gli algoritmi. In ballo ci sono le forme istituzionali del vivere civile, le dinamiche economiche, le relazioni sociali. È urgente assicurare nuovi percorsi legislativi e nuove pratiche sociali perché l’intelligenza artificiale può portare benefici all’intera società — pensiamo alle applicazioni in campo medico — ma a patto che le sue applicazioni pratiche siano guidate da regole chiare sul piano giuridico ed etico. Altrimenti è come cancellare la categoria mentale del bene e del male.
Più banalmente un’altra crepa concettuale si è insinuata nella percezione comune: quella tra vero e falso. I social network consentono di essere costantemente on-line e di far vivere il nostro alter ego virtuale in modo continuo e parallelo alla nostra vita quotidiana e permettono a chiunque di crearsi un’identità alternativa, virtuale, che, oltre a configurarsi come identità “pubblica”, aiuta a filtrare tutte le informazioni riguardanti il soggetto e di selezionare solo quello che si vuole rappresentare agli occhi degli altri. Il doppio virtuale può diventare in definitiva un doppio “ripulito” da condividere, mentre ciò che è socialmente meno accettabile o inaccettabile rimane circoscritto al campo del reale. In modo analogo ma opposto, la creazione di un doppio virtuale può essere funzionale alla manifestazione di desideri e pulsioni socialmente inconfessabili. Dunque, al profilo ufficiale si sostituisce un’identità fittizia attraverso la quale si rende possibile l’appagamento — spesso solo virtuale — degli istinti meno presentabili. Peraltro, vi sono casi in cui l’individuo si crea identità virtuali multiple, rappresentanti ciascuna uno o più aspetti della propria personalità. Non riuscendo a trovare una coesione tra i propri differenti aspetti, praticamente li rappresenta separatamente, a seconda del target a cui si rivolge, che nel mondo digitale si estende esponenzialmente rispetto alle relazioni possibili nel reale. È come un’esplosione all’ennesima potenza delle dinamiche dell’Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, come una frantumazione dell’io che si ricompone nell’amplificazione narcisistica.
Si può dire che la trasformazione digitale ha il potere di rendere le persone “avatar” di se stesse, annullando le convenzioni identitarie, sociali, politiche, sessuali. E in un siffatto arcipelago virtuale di identità diventa sempre più difficile individuare il senso della responsabilità. La responsabilità è dentro la persona e verso la persona. La sfida pertanto non consiste nella demonizzazione della tecnologia, ma nella difesa della coscienza interiore e della conoscenza, nel riconoscimento di quel disagio che chiamiamo vergogna e che ci distingue dal gemello digitale.
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-06/quo-141/e-poi-venne-il-gemello-digitale.html
Un libro per riconoscere la parità degli Stati e il primato della politica
Fausta Speranza – Città del Vaticano
“Oggi si pensa che la politica in generale, ma soprattutto la politica internazionale, sia valida se si basa su quello che è chiamato il principio di realismo, ma è falso”. Ne è sicuro l’ambasciatore Pasquale Ferrara, attualmente direttore generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del ministero degli Affari Esteri italiano, che affianca al servizio diplomatico l’attività accademica e di ricerca sulla teoria e la pratica delle relazioni internazionali. “Il principio di realismo – spiega – nasce dal presupposto che il mondo è popolato sostanzialmente da avversari, se non da nemici, e che bisogna anticipare le mosse”. Tanto che si è coniato il motto antichissimo: “Se vuoi la pace prepara la guerra”. In realtà preparando la guerra si ottiene solo la guerra. Un esempio storico fra gli altri è la Prima Guerra mondiale probabilmente scoppiata per una corsa agli armamenti navali tra Germania e Gran Bretagna.
Proprio su questo punto Ferrara si sofferma con Vatican News per parlare dell’orizzonte diverso indicato dal suo libro Cercando un paese innocente. La pace possibile in un mondo in frantumi, edito da Città Nuova:
Professor Ferrara, nel suo libro lei introduce la parola innocenza. Perché?
Perché l’innocenza è qualche cosa che ispira fiducia. La “moneta” mancante oggi nelle relazioni internazionali è proprio la fiducia che serve coltivare se si vuole la pace. Non significa innocenza nel senso di ingenuità, ma piuttosto di assenza di secondi fini; capacità di tener fede alla parola data; rifiuto di intenti aggressivi. Credo che la categoria dell’innocenza possa diventare anche una categoria politica.
Abbiamo costruito negli ultimi 60 anni una “architettura di pace”: non si possono negare tanti passi avanti in tema di diritti, di riconoscimento del principio di multilateralismo e via dicendo… Ora ci sembra che questa architettura stia dondolando, addirittura sgretolandosi? Che succede?
In realtà non siamo stati in grado di relegare davvero la guerra agli archivi della storia. Il sistema del multilateralismo, in particolare la “costruzione” delle Nazioni Unite, si basa sul principio della sicurezza collettiva, cioè fare in modo che le questioni vengano risolte all’interno di un organismo di compensazione, rappresentato in particolare dal Consiglio di Sicurezza. Ci eravamo illusi che con la fine della guerra fredda questi organismi potessero funzionare al meglio. In realtà, constatiamo – non solo a seguito dell’aggressione russa contro l’Ucraina ma già da prima – la paralisi proprio del maggior organismo che dovrebbe garantire la sicurezza internazionale: il Consiglio di Sicurezza non è più in grado di prendere decisioni perché esiste, come sappiamo bene, l’istituto del veto da parte di cinque membri permanenti. La globalizzazione sostanzialmente ha rappresentato il tentativo di estensione del modello liberal democratico a vaste aree del pianeta e questo processo è stato visto da molti Paesi, soprattutto dell’Africa, dell’America Latina, o alcuni dell’Asia, come il tentativo di imporre un modello che è il modello occidentale: da parte occidentale viene percepito come “ordine” ma da altre parti del mondo viene percepito come “disordine”, e lo è se consideriamo le mancate risposte ai bisogni di molte aree del pianeta.
Ci siamo illusi che con l’economia si risolvessero le questioni?
Esattamente. Non dobbiamo dare credito alla tesi del cosiddetto “scontro di civiltà” ma sicuramente c’è stata una sottovalutazione della pari dignità degli Stati. La vera cultura liberale inclusiva delle Nazioni Unite dovrebbe significare che tutti gli Stati indipendentemente dalla loro posizione geografica e dalla loro forza – sia in termini economici, sia in termini demografici, sia in termini militari – debbano avere pari dignità, un posto nella governance globale. Questo in realtà non è avvenuto. Conosciamo benissimo le disparità a livello economico, macroeconomico, ma anche le diseguaglianze in termini microeconomici di sicurezza umana delle persone. Queste disparità si sono acuite grandemente nel corso degli ultimi 20-30 anni. In questo senso, tutta la costruzione successiva alla seconda guerra mondiale presenta elementi di grande crisi di legittimità.
Anche da parte dei cittadini occidentali è maturato scetticismo nei confronti degli organismi ritenuti “sovranazionali”, come l’Unione Europea o le Nazioni Unite, sebbene siano organi estremamente diversi. Si parla di un eccessivo peso dell’economia sulla politica. È d’accordo?
Sicuramente c’è da recuperare la voce della politica. Ma bisogna ricordarsi che la dimensione economica può anche essere uno spazio politico. Mettere insieme il carbone e l’acciaio durante la seconda guerra mondiale era un fatto economico che però ha avuto un grandissimo valore politico: si trattava precisamente delle risorse che erano servite perché Germania e Francia si facessero la guerra per oltre mezzo secolo. Quindi questa sicuramente è stata una strada economica per un patto di pace politico. È un altro discorso, invece, se si dà spazio all’ideologia del mercato: ci si pone su un piano diverso rispetto a quello dell’integrazione economica. Su questo piano le liberalizzazioni spesso sono state fatte senza tener conto delle necessità dei cittadini e soprattutto senza tener conto anche degli aspetti che fanno parte di quello che i francesi chiamano “l’eccezione culturale”, che significa tener conto che alcune decisioni non possono presupporre omogeneità in un continente variegato come quello europeo. Inoltre pensiamo alle riforme economiche, per esempio l’adozione dell’euro rappresenta una grande impresa politica: ha a che fare con la moneta e la moneta sin dall’antichità è il simbolo della sovranità. Il fatto di condividere l’euro tra diversi Paesi Ue è anche un segnale politico forte.
Parlando di desiderio di pace, non vorremmo un pacifismo cieco ma vorremmo sentire una decisa volontà dei cittadini, di tutti, a difendere o ricostruire la pace. C’è questa volontà?
Credo che a dispetto di un certo discredito per l’espressione del pacifismo, anche per un uso a volte improprio o talvolta strumentale che ne è stato fatto da una parte o dall’altra, anche se non da tutti, il cuore del concetto sia la preservazione della pace e credo che resti un aspetto fondamentale. Spesso interpretiamo la storia dell’umanità, e soprattutto la storia degli ultimi due secoli, come un susseguirsi di guerre. In realtà credo che soffriamo un po’ di una distorsione prospettica, perché la gran parte delle epoche ha conosciuto lunghissimi periodi di pace. La guerra è un vulnus e perciò la avvertiamo come qualcosa di importante, di centrale, ma la vera centralità è rappresentata dalla normalità della condizione di pace. Quindi se noi vediamo le cose in quest’altra prospettiva, recuperiamo anche l’idea di pace come un fatto che ha a che fare con la stessa struttura della politica.
Parliamo dunque di politica di pace?
Una cosa è una politica di pace che sicuramente è importante, perché mira a raggiungere condizioni di stabilizzazione dopo conflitti di varia natura, e ce n’è bisogno anche se è molto impegnativo, e un conto è la pace come politica, che significa guardare tutte le politiche – anche le politiche sociali o economiche, le politiche migratorie – dalla prospettiva della pace. Non si limita a mettere fine a conflitti, ma tende a fare in modo che si creino le condizioni per cui i conflitti non abbiano a scoppiare. Serve un cambiamento di approccio molto concreto.
Significa parlare di “realismo utopico”, come lei fa nel suo libro?
Sì, nel senso che noi spesso siamo abituati a ritenere lo status quo, cioè ad esempio la condizione attuale di “disordine”, la guerra, come qualcosa destinato a durare e riteniamo che sia molto difficile cambiare gli equilibri mondiali. In realtà, se guardiamo alla storia, gli equilibri sono cambiati tante volte: in alcuni momenti lo status quo che sembrava granitico si è sgretolato prima del previsto, accade qualcosa che nessuno aveva previsto come la caduta del muro di Berlino. Dunque, se noi utilizziamo questa categoria del “realismo utopico” guardiamo alla situazione del presente perfettamente consapevoli che non è destinato a durare per sempre. Contrariamente al “realismo classico”, che esalta sostanzialmente le virtù della forza negli equilibri di potenza, il “realismo utopico” mira a gestire il cambiamento attraverso meccanismi di collaborazione: il multilateralismo è in crisi sicuramente ma è l’unico strumento che abbiamo per poter affrontare problemi globali come, per esempio, il cambiamento climatico.
L’importanza del ruolo delle religioni: non è soltanto un contributo di belle parole …
No, affatto. Pensiamo al ruolo che le religioni stanno avendo oggi nel generare una cultura che si muove nella direzione di una politica planetaria, non più di una politica semplicemente mondiale, ma planetaria che cioè tiene conto della vita sul pianeta. Nelle religioni c’è quest’idea della famiglia umana universale e parte di questa famiglia sono anche tutte le componenti non umane perché contribuiscono alla sussistenza dell’umanità su questa terra. Quindi il tema è allargare gli orizzonti e le religioni possono contribuire proprio a questa operazione di ampliamento dello sguardo.
A volte nell’ambito della politica internazionale si è guardato alle religioni come “parte del problema” dei conflitti…
Perché se strumentalizzate possono essere utili ad alimentare i fondamentalismi che rendono i conflitti intrattabili. Oggi siamo nelle condizioni di poter dire che le religioni stanno diventando parte della soluzione in molti conflitti, in molti ambiti. Rileggendo le due grandi encicliche di Papa Francesco – Laudato si’ e Fratelli tutti – ci si rende conto di quanto sia andata in profondità questa consapevolezza che le religioni hanno una responsabilità per il destino dell’umanità e anche per le sorti del pianeta. Questa visione olistica – che non ha niente a che fare con la vecchia idea del panteismo, naturalmente – nasce dall’idea dell’unità del genere umano e della unitarietà della vita sul pianeta, che ci è consegnato perché sopravviva e ci faccia sopravvivere. Non ci è consegnato per scopi predatori.
Quanto è cruciale la questione dell’identità e delle culture?
Sì, il tema delle identità è tornato in auge: sono importanti, purché non si cristallizzino. Alcuni antropologi spiegano che siamo abituati a pensare l’identità associandola alle radici, che rappresentano l’humus da cui si trae linfa vitale, come letterature o culture popolari, ma si può pensare alle identità anche come a una grande corrente fluviale: lo stesso fiume mantiene dignità di fiume e al tempo stesso non è mai identico a se stesso, anzi si alimenta di contributi, di immissioni diverse e in un certo modo cambia continuamente. E lo scrittore Amin Maalouf fa una distinzione utilissima tra identità e appartenenze riconoscendo che l’identità di ognuno è fatta di mille appartenenze: siamo quello che siamo perché apparteniamo a una famiglia, una società, un Paese, magari siamo legati a un associazionismo sportivo… Questo insieme di appartenenze, che è diverso per ciascuno di noi, crea la nostra identità. Questo stesso meccanismo è riportabile anche sul piano dei popoli, delle nazioni, degli Stati, che sono comunque il risultato di diversi influssi e di molteplici appartenenze. Se l’identità è un insieme di fattori, in quell’insieme è più facile incontrarsi anche tra identità diverse.
Ma quanto è importante ancorarci al concetto di cittadinanza quando parliamo di identità?
La cittadinanza è fondamentale, perché altrimenti siamo una semplice convivenza, una coesistenza pacifica tra individui, se va bene. La cittadinanza è qualcosa che implica non tanto una partecipazione, che è una parola abusata, ma un’assunzione di responsabilità. Certamente va declinata più in termini di demos, di un popolo che esercita alcuni diritti e doveri, piuttosto che in termini più granitici e meno inclusivi di ethnos. In un mondo che possiamo anche immaginare non più governato dalla globalizzazione, ma che sicuramente rimarrà caratterizzato dalla mondialità.
Nel suo libro parla in un certo senso di “abuso” di geopolitica. Ci spiega?
La geopolitica ovviamente è una scienza nobile e intesa in senso corretto aiuta molto a capire i meccanismi internazionali. Il tema è che talvolta la geopolitica viene utilizzata come una sorta di pretesto per giustificare scelte politiche. Dobbiamo rivalutare la centralità della politica, perché se ci limitiamo a determinanti geografiche togliamo qualsiasi ruolo alla capacità di governo del mondo e di governo dei processi. La geopolitica è troppo spesso legata al cosiddetto hard power, quindi al potere militare, al potere economico, al potere demografico e quindi alla fine ha poco a che fare con la pace. Se si enfatizza la geopolitica, si finisce inevitabilmente sul piano delle politiche di potenza e quindi si sancisce l’impotenza della politica. Senza diventare dogmatici, occorre rivendicare l’autonomia decisionale della politica anche in politica estera. Bisogna sempre rimettere al centro le scelte coraggiose.