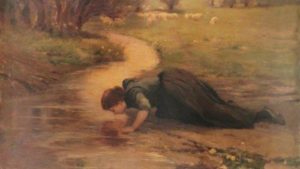A 27 anni dal genocidio, il Paese nel cuore dell’Africa orientale ha ricostruito il tessuto sociale con atti di perdono particolarissimi. Intanto, si combatte il negazionismo e restano forti le tensioni etniche nei territori vicini, come spiega l’africanista Anna Bono
Fausta Speranza – Città del Vaticano
La sera del 6 aprile 1994 un razzo proveniente da una delle tante colline di Kigali colpì l’aereo in cui viaggiavano Juvénal Habyarimana e Cyprien Ntaryamira, rispettivamente i presidenti di Ruanda e Burundi, entrambi di etnia hutu. Probabilmente non si saprà mai l’identità del responsabile di tale attacco. Un’ipotesi attribuisce agli estremisti hutu, contrari ai negoziati di pace con le forze ribelli tutsi e ostili agli accordi di power sharing firmati ad Arusha, le responsabilità dell’abbattimento dell’aereo su cui viaggiavano i due capi di Stato. Opposta a questa, la ricostruzione secondo cui il missile terra-aria che colpì l’aereo di Habyarimana fu lanciato dai ribelli tutsi delle forze FPR, Front Patriotique Rwandais, agli ordini di Paul Kagame. Di certo c’è che l’abbattimento del velivolo è stata la scintilla che ha fatto scoppiare l’ultimo genocidio del ventesimo secolo.
L’accorato appello di Giovanni Paolo II
Al Regina Coeli del 10 aprile 1994, Giovanni Paolo II lanciava un rinnovato accorato appello perché cessasse la spirale di morte e di violenza che insanguinava il Rwanda. Queste le parole del Papa riconosciuto Santo:
“Le tragiche notizie che giungono dal Rwanda suscitano nell’animo di tutti noi una grande sofferenza. Un nuovo indicibile dramma: l’assassinio dei Capi di Stato di Rwanda e Burundi e del seguito; il Capo del Governo Rwandese e la sua famiglia e del seguito; il Capo del Governo Rwandese e la sua famiglia trucidati; sacerdoti, religiosi e religiose uccisi. Ovunque odio, vendette, sangue fraterno versato. In nome di Cristo, vi supplico, deponete le armi, non rendete vano il prezzo della Redenzione, aprite il cuore all’imperativo di pace del Risorto! Rivolgo il mio appello a tutti i responsabili, anche della Comunità Internazionale, perché non desistano dal cercare ogni via che possa porre argine a tanta distruzione e morte.”
100 giorni di violenze inaudite
Almeno 900.000 morti tra tutsi e hutu. Molti di questi sono stati massacrati a colpi di machete, spranghe e coltelli. Dell’etnia tutsi, la più colpita, sopravvissero in 300.000. La mattanza è durata cento giorni. Le milizie paramilitari interahamwe e impuzamugambi, esponenti dell’esercito nazionale, amministratori locali e semplici cittadini di etnia hutu, accompagnati dalla feroce propaganda di Radio Milles Collines che invitava a sterminare quelli che definiva gli “scarafaggi”, hanno ucciso sistematicamente membri delle comunità tutsi e altri delle comunità hutu considerati moderati massacrandoli a colpi di machete e armi da fuoco.
Le “mancanze che hanno deturpato il volto della Chiesa”
Il 20 marzo 2017, incontrando in Vaticano Paul Kagame, Papa Francesco ha espresso “l’implorazione di perdono a Dio per i peccati e le mancanze della Chiesa e dei suoi membri” negli anni Novanta, mancanze che “hanno deturpato il volto della Chiesa”. Così si legge nel bollettino della Sala Stampa vaticana di quel giorno: “Durante i cordiali colloqui sono state ricordate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Rwanda. Si è apprezzato il notevole cammino di ripresa per la stabilizzazione sociale, politica ed economica del Paese. È stata rilevata la collaborazione tra lo Stato e la Chiesa locale nell’opera di riconciliazione nazionale e di consolidamento della pace a beneficio dell’intera Nazione. In tale contesto il Papa ha manifestato il profondo dolore suo, della Santa Sede e della Chiesa per il genocidio contro i Tutsi, ha espresso solidarietà alle vittime e a quanti continuano a soffrire le conseguenze di quei tragici avvenimenti e, in linea con il gesto compiuto da San Giovanni Paolo II durante il Grande Giubileo del 2000, ha rinnovato l’implorazione di perdono a Dio per i peccati e le mancanze della Chiesa e dei suoi membri, tra i quali sacerdoti, religiosi e religiose che hanno ceduto all’odio e alla violenza, tradendo la propria missione evangelica. Il Papa ha altresì auspicato che tale umile riconoscimento delle mancanze commesse in quella circostanza, le quali, purtroppo, hanno deturpato il volto della Chiesa, contribuisca, anche alla luce del recente Anno Santo della Misericordia e del Comunicato pubblicato dall’Episcopato rwandese in occasione della sua chiusura, a ‘purificare la memoria’ e a promuovere con speranza e rinnovata fiducia un futuro di pace, testimoniando che è concretamente possibile vivere e lavorare insieme quando si pone al centro la dignità della persona umana e il bene comune.”
Il ruolo delle forze di pace
All’inizio degli scontri sono stati uccisi anche dieci caschi blu belga. Nonostante i segnali di allarme lanciati dal generale canadese, Roméo Dallaire, a capo della missione UNAMIR (UN Assistance Mission for Rwanda), il mandato delle Nazioni Unite non è stato rafforzato. L’uccisione del contingente di militari belgi e del primo ministro Agathe Uwilingiyimana a opera di miliziani hutu ha rappresentato un evento traumatico per l’organizzazione internazionale, che decise il ridimensionamento del numero di caschi blu presenti nel Paese, da 2.500 a 270. La violenza si è fermata solo a metà luglio quando i soldati dell’attuale presidente, Paul Kagame, sono entrati nella spettrale capitale Kigali.
La lunga presidenza Kagame
Da quel momento Kagame, rieletto per tre mandati, ha guidato il Paese. Nel 2017 per potersi candidare al terzo mandato ha ottenuto un emendamento alla Costituzione e ha poi raccolto – caso unico al mondo – il 99 per cento dei consensi. Kagame continua ad essere accusato di autoritarismo rispetto alla popolazione e di brutalità nei confronti dei suoi oppositori, alcuni dei quali sono stati imprigionati o uccisi. Come ogni anno, il presidente Paul Kagame e sua moglie hanno commemorato tutte le vittime durante una cerimonia a Gisozi.
Il cammino sociale
Il Rwanda ha fatto molti progressi, in particolare legati al ruolo della donna, della salute, dell’insegnamento e dell’economia. Il sistema sanitario e quello scolastico sono in gran parte gratuiti. Della ricostruzione del tessuto sociale abbiamo parlato con l’africanista Anna Bono:
L’esperta Anna Bono sottolinea che a livello sociale molto è stato fatto per promuovere pace sociale anche con il sussidio di vari organismi internazionali che hanno organizzato perfino incontri a livello personale tra carnefici e familiari delle vittime. E questo è accaduto mentre il Paese ha conosciuto anni di crescita economica. Bono ricorda che anche in Rwanda non mancano le difficoltà per la pandemia e le ripercussioni economiche, ma che in generale è anche il Paese considerato dagli investitori stranieri come lo Stato con il più basso livello di corruzione in Africa.
Il rischio negazionismo
La professoressa Bono sottolinea che le immagini di centinaia di cadaveri abbandonati per la strada, gettati nei corsi d’acqua o bruciati nelle chiese rimangono impresse nella memoria dei sopravvissuti e di chi ha seguito gli sviluppi dello sterminio, anche perché sono state pochissime le famiglie che non hanno avuto vittime o che non sono state coinvolte in fatti di sangue. Ma spiega che, di fronte alla nascita di correnti di negazionismo, il parlamento ruandese ha emanato leggi che criminalizzano qualunque forma di revisione storica che neghi l’accaduto. Bono sottolinea che il negazionismo potrebbe essere il primo passo per riaccendere tensioni etniche che – avverte – hanno radici antiche sul territorio africano e che il colonialismo in alcuni casi, ad esempio con l’ufficializzazione delle divisioni etniche tra hutu, tutsi, ha accentuato. Bono ricorda che oltre due milioni di profughi di etnia hutu si sono riversati, al momento delle violenze, nella vicina Repubblica Democratica del Congo e restano ancora oggi al centro di tensioni che preoccupano la comunità internazionale.
Gli archivi
Il 26 marzo scorso una commissione di storici voluta dal governo francese ha concluso che la Francia ha avuto pesanti responsabilità, come ha sottolineato anche Vincento Duclert, uno degli autori del rapporto. Non sono mai state riscontrate responsabilità dirette sui massacri ma si parla di sostegno al regime dittatoriale dell’allora presidente Juvénal Habyarimana. Dunque, il 7 aprile, riconosciuta dall’Onu come Giornata Mondiale della Memoria in onore delle vittime del genocidio in Rwanda, Parigi, per la prima volta quest’anno, ha aperto al grande pubblico importanti archivi relativi alla situazione in Rwanda. Una sorta di memoriale con numerosi documenti, in particolare telegrammi e note confidenziali. Parigi è stata accusata di aver garantito copertura politica al regime di Habyarimana, di aver addestrato e armato l’esercito rwandese e le milizie hutu, di aver dato appoggio al Gouvernement Intérimaire Rwandais (GIR) costituito in seguito alla morte del presidente e considerato pienamente responsabile del genocidio. L’accusa, inoltre, è di aver supportato le Forces Armées Rwandaises di fronte all’avanzata dei ribelli dell’FPR, nonché di aver offerto protezione agli autori materiali dei massacri, attraverso la costituzione di una ‘zona sicura’ al confine con lo Zaire di Mobutu. Si tratta di tutte accuse respinte da Parigi che però hanno compromesso le relazioni tra la Francia e il governo ruandese di Paul Kagame, ex leader dell’FPR. Solo recentemente, Parigi e Kigali hanno intrapreso un processo di riavvicinamento. E proprio in questi giorni Kagame ha espresso parole di apprezzamento per i passi in avanti voluti dal presidente Macron.