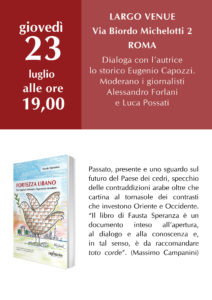Uomini, donne e bambini vittime di lavoro forzato, prostituzione, traffico di organi. Crimini che non si sono fermati con la pandemia e che vanno combattuti a tutti i livelli della società. Il cardinale sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale riflette sull’impegno della Chiesa e sull’urgenza di mettere in discussione comportamenti sociali che alimentano la “domanda” di sfruttamento
Fausta Speranza – Città del Vaticano
Si stima che circa 40 milioni di persone siano vittime nel mondo di tratta. Secondo il Rapporto sul traffico di esseri umani dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), quasi un terzo sono minori. Inoltre, il 71% del totale è costituito da donne e bambine. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) denuncia che 21 milioni di persone siano vittime di lavoro forzato, spesso collegato anche allo sfruttamento sessuale. C’è poi il drammatico fenomeno del traffico degli organi che sfugge alle stime, ma che resta un innegabile risvolto. Della drammaticità e della pervasività del fenomeno, che interessa tutti i Paesi, di origine, di transito o di destinazione delle vittime, abbiamo parlato con il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale:
Ascolta l’intervista con il cardinale Michael Czerny:
R. La più grande risposta da parte di tutta la Chiesa si trova nell’impegno delle suore della rete Thalita Khum. E così, per la Sezione rifugiati e migranti del Dicastero, la prima priorità è accompagnare la rete, collaborare, appoggiare, suggerire, facilitare… Facciamo ciò che possiamo perché in tanti Paesi del mondo le suore stanno rispondendo veramente a nome della Chiesa e a nome di Cristo. É importantissimo riconoscere questo lavoro, perché loro non parlano, ma agiscono. Noi allora possiamo parlarne un po’.
Indubbiamente la pandemia ha rappresentato un fattore di complicazione di tutto questo impegno…
R. – Certo. Ha complicato l’impegno delle suore, ma grazie a Dio, grazie all’aiuto dello Spirito Santo, loro hanno trovato sempre i mezzi per continuare a portare avanti il ministero. Non si sono rassegnate a tre mesi o sei mesi di lockdown. No: hanno cambiato mezzi o metodi e hanno continuato. La grande tristezza è che in questi mesi di pandemia si è assistito ad un terribile aumento della tratta e questo deve scandalizzarci. Mentre tutti noi – “i buoni” – siamo rinchiusi in casa, come mai la domanda aumenta e non diminuisce? Questo indica che le radici del problema si trovano nelle case, nel cuore delle persone, dei cittadini, di fratelli e sorelle che ci sono intorno. Questa connessione fra la tratta e la vita apparentemente normale di persone apparentemente normali è un grande scandalo che deve farci riflettere, chiedere perdono a Dio, per cercare la necessaria conversione per ridurre e eliminare la domanda che è il motore della tratta.
Diciamo che i due fronti sono il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale, quindi donne e bambini in tutti e due i casi sono in prima linea, anche insieme con tanti uomini ovviamente…
R. – Esatto. Lei ha menzionato la prostituzione, che include adesso, in modo particolare, tutto lo sfruttamento online e il lavoro forzato; include anche il traffico di organi, un crimine per il quale non ci sono parole, e altri aspetti, come l’uso delle persone per trasportare la droga … Tutti questi sono impegni o “imprese” della tratta.
Eminenza, dal 2013 ricordiamo la Giornata internazionale voluta dall’Onu contro la tratta di esseri umani. Nel 2015 c’è stato un impegno sottoscritto dai governi del mondo a combattere questo che spesso viene definito un fenomeno, ma – lo ricordiamo – è un crimine vero e proprio. In questi anni che cosa è stato fatto e che cosa invece non viene affrontato davvero?
R. – Questa è una buona domanda, uno spunto per approfondire. Voglio dire che alla fine la somma degli sforzi potrebbe essere meno importante dei singoli sforzi specifici, perché sono persone, uomini, donne e bambini, le vittime della tratta, i quali vengono sfruttati e abusati. In questo senso, voglio dire che ciò che è interessante è l’aumento di coscienza, direi mondiale; questo per noi è l’aspetto più importante. E in questi anni si è visto lo sviluppo di consapevolezza. Vediamo anche lo sviluppo di tanti nuovi ministeri della Chiesa per affrontare questa piaga: dalla prevenzione, al riscatto, alla riabilitazione, all’integrazione delle persone. E’ importante per tutti a tutti i livelli, renderci conto di ciò che noi stessi diciamo, appoggiamo e provochiamo con le nostre scelte. Il nostro impegno non deve essere quello di contare i numeri, ma di renderci conto che sono le scelte che io faccio che appoggiano in qualche modo e contribuiscono alla tratta. E non dico di guardare solo agli altri o ai cattivi, ma alle scelte di ognuno. Io, che scelte faccio, ad esempio quando compro un telefonino? Quando faccio un viaggio? Quando mi permetto un piacere? E non entro nel dettaglio.
Eminenza, per il cristiano è scontato o dovrebbe essere scontato che l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, quindi il rispetto della persona. In una società che vanta la proliferazione, la rivendicazione di tanti diritti, questo non è più scontato, non è più così condivisibile…
R. – Sì, forse. Io penso che ogni diritto ha qualcosa di vero. Forse tutti non vanno così bene nell’insieme, o forse non tutti i diritti hanno lo stesso livello o valore, ma in genere non sono cattivi in quanto tali. Il punto è la cultura dello scarto, una cultura del piacere non istantaneo o necessario, obbligatorio. Dobbiamo riflettere su alcuni “bisogni”, quando si sente dire “ho bisogno di questo piacere, di questo prodotto, ho bisogno di questo prezzo basso” … Penso che queste compulsioni siano più al cuore del problema della tratta che la proliferazione dei diritti o cosiddetti diritti.
L’esperienza di Thalita Khum in tempo di pandemia
Alla grande risposta della Chiesa alla piag della tratta appartiene dunque l’esperienza di Talitha Kum, rete mondiale della vita consacrata impegnata contro la tratta di persone . Suor Gabriella Bottani, coordinatrice internazionale dell’organizzazione, sottolinea che le condizioni di vulnerabilità stanno aumentando e toccando un maggior numero di persone, soprattutto a causa di situazioni di povertà estrema che, a loro volta, facilitano l’attività dei trafficanti. Tra i principali gruppi colpiti vi sono le donne, i bambini, le minoranze etniche, i cittadini stranieri, soprattutto quelli senza documenti, e le popolazioni indigene. Oltre alla diffusione del virus, il principale fattore che contribuisce a incrementare tale vulnerabilità è la perdita del lavoro. Il mercato del lavoro è un settore chiave per i reclutatori al fine di trascinare le persone nella rete dello sfruttamento. Secondo i dati di Thalita Khum, la violenza domestica contro le donne e i bambini risulta in aumento. Pur non facendo parte del traffico in quanto tale, questa può causarlo indirettamente, perché la violenza domestica può costringere le persone ad accettare qualsiasi via di fuga. In aggiunta, alcune delle misure sociali e sanitarie attuate a livello mondiale per contenere il Covid-19 hanno avuto un impatto sui migranti, soprattutto quelli senza documenti e senza permesso di soggiorno. Tra questi ci sono molte vittime di tratta. La pandemia, peraltro, ha avuto effetti sul lavoro di Thalitha Kum: missionari e volontari si sono rivolti ai social media per continuare la missione mantenendo il contatto umano con le vittime della tratta in modo virtuale, e a tal fine si è resa necessaria una formazione specifica.
[ Read Also ]
L’appello Caritas: misure urgenti e mirate
Il segretario generale di Caritas Internationalis, Aloysius John, afferma che “in questo momento di diffusione del Covid-19, le persone vulnerabili sono maggiormente a rischio di divenire vittime della tratta”. La Confederazione delle 162 Caritas nazionali e la rete anti-tratta cristiana sottolineano come il Covid-19 abbia focalizzato l’attenzione dei governi in ambito sanitario, impedendo tuttavia che potesse essere prestata sufficiente attenzione ai danni collaterali della pandemia globale, specialmente sui migranti e lavoratori informali, ora più esposti alla tratta e allo sfruttamento. Caritas Internationalis e Coatnet chiedono, dunque, misure urgenti e mirate per sostenere quanti lavorano in settori informali, tra cui i collaboratori domestici e gli operai agricoli e edili, tra i quali si trovano i lavoratori più vulnerabili, come ad esempio i migranti privi di documenti.
La denuncia di Save the children
Ben 10 milioni delle vittime di tratta nel mondo, ossia 1 su 4, hanno meno di 18 anni e, in un caso su 20, addirittura le vittime hanno meno di 8 anni. La forma più diffusa di sfruttamento resta quella sessuale (84,5 per cento) che vede principalmente come vittime donne e ragazze. Rispetto al totale, il 95 per cento ha un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Il fenomeno però resta prevalentemente sommerso e, con l’emergenza Covid-19, ha visto trasformare alcuni modelli tipici della tratta e dello sfruttamento dei minori. I gruppi criminali dediti allo sfruttamento sessuale in particolare, sottolinea Save the Children, sono stati ovunque rapidissimi nell’adattare il loro modello operativo attraverso l’uso intensivo della comunicazione online e dello sfruttamento nelle case, “indoor”, e il lockdown ha costretto le istituzioni e le organizzazioni non governative ad affrontare maggiori difficoltà nelle attività di prevenzione e supporto alle vittime. Inoltre, dai dati di Save the children emerge che in Europa, è boom di pedopornografia.
Onu: un percorso di consapevolezza e di intenti
Nel 2010, l’Assemblea Generale ha adottato un Piano Globale d’Azione per la lotta alla tratta di esseri umani e ha esortato i governi di tutti i Paesi a intraprendere azioni coordinate e coerenti per sconfiggere questa piaga. Il Piano esprime la necessità di includere la lotta al traffico nei programmi più ampi delle Nazioni Unite, affinché lo sviluppo e la sicurezza a livello mondiale vengano rafforzati. Una delle principali disposizioni del Piano è la creazione di un fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite, in particolare per donne e bambini. Nel 2013 l’Assemblea Generale ha tenuto un incontro di alto livello per la valutazione del Piano Globale d’Azione. I Paesi Membri hanno adottato la risoluzione A/RES/68/192, designando il 30 luglio come ricorrenza per la Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. La risoluzione l’importanza di questa ricorrenza “nel far conoscere la situazione delle vittime della tratta di esseri umani e nella promozione e protezione dei loro diritti”. E, a settembre 2015, i governi di tutto il mondo hanno aderito all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile accogliendo anche gli obiettivi e i target che riguardano la tratta. Si chiede di porre fine al più presto al traffico e alla violenza sui bambini, di mettere in atto misure atte a eliminare qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento di donne e bambini. Un altro importante avvenimento è stato il Summit per i Rifugiati e i Migranti che ha portato alla Dichiarazione di New York che contiene 19 “promesse” di cui tre sono volte ad azioni concrete contro la tratta di esseri umani.